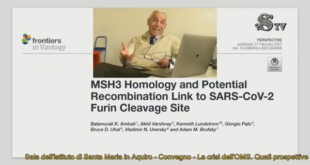La chiesa cattolica è l’unica religione a disporre di una dottrina sociale, fondata sulla lotta alla povertà e la demonizzazione del danaro, “sterco del diavolo”. Vangelo secondo Matteo: “E’ più facile che un cammello passi nella cruna dell’ago, che un ricco entri nel regno dei cieli”. Ma è anche l’unica religione ad avere una propria banca per maneggiare affari e investimenti, l’Istituto Opere Religiose.
La sede dello IOR è uno scrigno di pietra all’interno delle mura vaticane. Una suggestiva torre del Quattrocento, fatta costruire da Niccolò V, con mura spesse nove metri alla base. Si entra attraverso una porta discreta, senza una scritta, una sigla o un simbolo. Soltanto il presidio delle guardie svizzere notte e giorno ne segnala l’importanza.
All’interno si trovano una grande sala di computer, un solo sportello e un unico bancomat.
Attraverso questa cruna dell’ago passano immense e spesso oscure fortune. Le stime più prudenti calcolano 5 miliardi di euro di depositi. La banca vaticana offre ai correntisti, fra i quali come ha ammesso una volta il presidente Angelo Caloia “qualcuno ha avuto problemi con la giustizia”, rendimenti superiori e un vantaggio inestimabile: la totale segretezza. Più impermeabile ai controlli delle isole Cayman, più riservato delle banche svizzere, l’istituto vaticano è un vero paradiso (fiscale) in terra. Un libretto d’assegni con la sigla IOR non esiste.
Tutti i depositi e i passaggi di danaro avvengono con bonifici, in contanti o in lingotti d’oro. Nessuna traccia.
Da vent’anni, quando si chiuse il processo per lo scandalo del Banco Ambrosiano, lo IOR è un buco nero in cui nessuno osa guardare. Per uscire dal crac che aveva rovinato decine di migliaia di famiglie, la banca vaticana versò 406 milioni di dollari ai liquidatori. Meno di un quarto rispetto ai 1.159 milioni di dollari dovuti secondo l’allora ministro del Tesoro, Beniamino Andreatta. Lo scandalo fu accompagnato da infinite leggende e da una scia di cadaveri eccellenti. Michele Sindona avvelenato nel carcere di Voghera, Roberto Calvi impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra, il giudice istruttore Emilio Alessandrini ucciso dai colpi di Prima Linea, l’avvocato Giorgio Ambrosoli freddato da un killer della mafia venuto dall’America al portone di casa.
Senza contare il mistero più inquietante, la morte di Papa Luciani, dopo soli 33 giorni di pontificato, alla vigilia della decisione di rimuovere Paul Marcinkus e i vertici dello IOR. Sull’improvvisa fine di Papa Luciani si sono alimentate macabre dicerie, aiutate dalla reticenza vaticana. Non vi sarà autopsia per accertare il presunto e fulminante infarto e non sarà mai trovato il taccuino con gli appunti sullo IOR che secondo molti testimoni il papa portò a letto l’ultima notte.
Paul Marcinkus, il figlio di un lavavetri lituano, nato a Cicero (Chicago) a due strade dal quartier generale di Al Capone, protagonista di una delle più clamorose quanto inspiegabili carriere nella storia recente della chiesa. Alto e atletico, buon giocatore di baseball e golf, era stato l’uomo che aveva salvato Paolo VI dall’attentato nelle Filippine. Ma forse non basta a spiegare la simpatia di un intellettuale come Montini, per questo prete americano perennemente atteggiato da avventuriero di Wall Street, con le mazze da golf nella fuoriserie, l’Avana incollato alle labbra, le stupende segretarie bionde e gli amici di poker della P2.
Con il successore di Papa Luciani, Marcinkus trova subito un’intesa. A Karol Wojtyla piace molto quel figlio di immigrati dell’Est che parla bene il polacco, odia i comunisti e sembra così sensibile alle lotte di Solidarnosc. Quando i magistrati di Milano spiccano mandato d’arresto nei confronti di Marcinkus, il Vaticano si chiude come una roccaforte per proteggerlo, rifiuta ogni collaborazione con la giustizia italiana, sbandiera i passaporti esteri e l’extraterritorialità. Ci vorranno altri dieci anni a Woytjla per decidersi a rimuovere uno dei principali responsabili del crac Ambrosiano dalla presidenza dello IOR. Ma senza mai spendere una parola di condanna e neppure di velata critica: Marcinkus era e rimane per le gerarchie cattoliche “una vittima”, anzi “un’ingenua vittima”.
Dal 1989, con l’arrivo alla presidenza di Angelo Caloia, un galantuomo della finanza bianca, amico e collaboratore di Giovanni Bazoli, molte cose dentro lo IOR cambiano. Altre no. Il ruolo di bonificatore dello IOR affidato al laico Caloia è molto vantato dalle gerarchie vaticane all’esterno quanto ostacolato all’interno, soprattutto nei primi anni. Come confida lo stesso Caloia al suo diarista, il giornalista cattolico Giancarlo Galli, autore di un libro fondamentale ma introvabile, Finanza bianca (Mondadori, 2003). “Il vero dominus dello IOR – scrive Galli – rimaneva monsignor Donato De Bonis, in rapporti con tutta la Roma che contava, politica e mondana. Francesco Cossiga lo chiamava Donatino, Giulio Andreotti lo teneva in massima considerazione. E poi aristocratici, finanzieri, artisti come Sofia Loren. Questo spiegherebbe perché fra i conti si trovassero anche quelli di personaggi che poi dovevano confrontarsi con la giustizia. Bastava un cenno del monsignore per aprire un conto segreto.
A volte monsignor De Bonis accompagnava di persona i correntisti con i contanti o l’oro nel caveau, attraverso una scala, in cima alla torre, “più vicino al cielo”. I contrasti fra il presidente Caloia e De Bonis, in teoria sottoposto, saranno frequenti e duri. Commenta Giancarlo Galli: “Un’aurea legge manageriale vuole che, in caso di conflitto fra un superiore e un inferiore, sia quest’ultimo a soccombere. Ma essendo lo IOR istituzione particolarissima, quando un laico entra in rotta di collisione con una tonaca non è più questione di gradi”.
La glasnost finanziaria di Caloia procede in ogni caso a ritmi serrati, ma non impedisce che l’ombra dello IOR venga evocata in quasi tutti gli scandali degli ultimi vent’anni. Da Tangentopoli alle stragi del ’93 alla scalata dei “furbetti” e perfino a Calciopoli. Ma come appare, così l’ombra si dilegua. Nessuno sa o vuole guardare oltre le mura impenetrabili della banca vaticana.
L’autunno del 1993 è la stagione più crudele di Tangentopoli. Subito dopo i suicidi veri o presunti di Gabriele Cagliari e di Raul Gardini, la mattina del 4 ottobre arriva al presidente dello IOR una telefonata del procuratore capo del pool di Mani Pulite, Francesco Saverio Borrelli: “Caro professore, ci sono dei problemi, riguardanti lo IOR, i contatti con Enimont…”. Il fatto è che una parte considerevole della “madre di tutte le tangenti”, per la precisione 108 miliardi di lire in certificati del Tesoro, è transitata dallo IOR. Sul conto di un vecchio cliente, Luigi Bisignani, piduista, giornalista, collaboratore del gruppo Ferruzzi e faccendiere in proprio, in seguito condannato a 3 anni e 4 mesi per lo scandalo Enimont e di recente rispuntato nell’inchiesta “Why Not” di Luigi De Magistris. Dopo la telefonata di Borrelli, il presidente Caloia si precipita a consulto in Vaticano da monsignor Renato Dardozzi, fiduciario del segretario di Stato Agostino Casaroli. “Monsignor Dardozzi – racconterà a Galli lo stesso Caloia – col suo fiorito linguaggio disse che ero nella merda e, per farmelo capire, ordinò una brandina da sistemare in Vaticano. Mi opposi, rispondendogli che avrei continuato ad alloggiare all’Hassler. Tuttavia accettai il suggerimento di consultare d’urgenza dei luminari di diritto. Una risposta a Borrelli bisognava pur darla!”. La risposta sarà di poche ma definitive righe: “Ogni eventuale testimonianza è sottoposta a una richiesta di rogatoria internazionale”.
I magistrati del pool valutano l’ipotesi della rogatoria. Lo IOR non ha sportelli in terra italiana, non emette assegni e, in quanto “ente fondante della Città del Vaticano”, è protetto dal Concordato: qualsiasi richiesta deve partire dal ministero degli Esteri. Le probabilità di ottenere la rogatoria in queste condizioni sono lo zero virgola. In compenso l’effetto di una richiesta da parte dei giudici milanesi sarebbe devastante sull’opinione pubblica. Il pool si ritira in buon ordine e si accontenta della spiegazione ufficiale: “Lo IOR non poteva conoscere la destinazione del danaro”.
Il secondo episodio, ancora più cupo, risale alla metà degli anni Novanta, durante il processo per mafia a Marcello Dell’Utri. In video conferenza dagli Stati Uniti il pentito Francesco Marino Mannoia rivela che “Licio Gelli investiva i danari dei corleonesi di Totò Riina nella banca del Vaticano”. “Lo IOR garantiva ai corleonesi investimenti e discrezione”. Fin qui Mannoia fornisce informazioni di prima mano. Da capo delle raffinerie di eroina di tutta la Sicilia occidentale, principale fonte di profitto delle cosche. Non può non sapere dove finiscono i capitali mafiosi. Quindi va oltre, con un’ipotesi. “Quando il Papa (Giovanni Paolo II, ndr) venne in Sicilia e scomunicò i mafiosi, i boss si risentirono soprattutto perché portavano i loro soldi in Vaticano. Da qui nacque la decisione di far esplodere due bombe davanti a due chiese di Roma”. Mannoia non è uno qualsiasi.
E’ secondo Giovanni Falcone “il più attendibile dei collaboratori di giustizia”, per alcuni versi più prezioso dello stesso Buscetta. Ogni sua affermazione ha trovato riscontri oggettivi. Soltanto su una non si è proceduto ad accertare i fatti, quella sullo IOR. I magistrati del caso Dell’Utri non indagano sulla pista IOR perché non riguarda Dell’Utri, ma passano le carte ai colleghi del processo Andreotti. Scarpinato e gli altri sono a conoscenza del precedente di Borrelli e non firmano la richiesta di rogatoria. Al palazzo di giustizia di Palermo qualcuno in alto osserva: “Non ci siamo fatti abbastanza nemici per metterci contro anche il Vaticano?”.
Sulle trame dello IOR cala un altro sipario di dieci anni, fino alla scalata dei “furbetti del quartierino”. Il 10 luglio dell’anno scorso il capo dei “furbetti”, Giampiero Fiorani, racconta in carcere ai magistrati: “Alla BSI Svizzera ci sono tre conti della Santa Sede che saranno, non esagero, due o tre miliardi di euro”. Al pm milanese Francesco Greco, Fiorani fa l’elenco dei versamenti in nero fatti alle casse vaticane: “I primi soldi neri li ho dati al cardinale Castillo Lara (presidente dell’Apsa, l’amministrazione del patrimonio immobiliare della chiesa, ndr), quando ho comprato la Cassa Lombarda. M’ha chiesto trenta miliardi di lire, possibilmente su un conto estero”.
Altri seguiranno, molti a giudicare dalle lamentele dello stesso Fiorani nell’incontro con il cardinale Giovanni Battista Re, potente prefetto della congregazione dei vescovi e braccio destro di Ruini: “Uno che vi ha sempre dato i soldi, come io ve li ho sempre dati in contanti, e andava tutto bene, ma poi quando è in disgrazia non fate neanche una telefonata a sua moglie per sapere se sta bene o male”.
Il Vaticano molla presto Fiorani, ma in compenso difende Antonio Fazio fino al giorno prima delle dimissioni, quando ormai lo hanno abbandonato tutti. Avvenire e Osservatore Romano ripetono fino all’ultimo giorno di Fazio in Bankitalia la teoria del “complotto politico” contro il governatore. Del resto, la carriera di questo strano banchiere che alle riunioni dei governatori centrali non ha mai citato una volta Keynes ma almeno un centinaio di volte le encicliche, si spiega in buona parte con l’appoggio vaticano. In prima persona di Camillo Ruini, presidente della Cei, e poi di Giovanni Battista Re, amico intimo di Fazio, tanto da aver celebrato nel 2003 la messa per il venticinquesimo anniversario di matrimonio dell’ex governatore con Maria Cristina Rosati.
Naturalmente neppure i racconti di Fiorani aprono lo scrigno dei segreti dello IOR e dell’Apsa, i cui rapporti con le banche svizzere e i paradisi fiscali in giro per il mondo sono quantomeno singolari. E’ difficile per esempio spiegare con esigenze pastorali la decisione del Vaticano di scorporare le Isole Cayman dalla naturale diocesi giamaicana di Kingston, per proclamarle “missio sui iuris” alle dirette dipendenze della Santa Sede e affidarle al cardinale Adam Joseph Maida, membro del collegio dello IOR.
Il quarto e ultimo episodio di coinvolgimento dello IOR negli scandali italiani è quasi comico rispetto ai precedenti e riguarda Calciopoli. Secondo i magistrati romani Palamara e Palaia, i fondi neri della Gea, la società di mediazione presieduta dal figlio di Moggi, sarebbero custoditi nella banca vaticana. Attraverso i buoni uffici di un altro dei banchieri di fiducia della Santa Sede dalla fedina penale non immacolata, Cesare Geronzi, padre dell’azionista di maggioranza della Gea. Nel caveau dello IOR sarebbe custodito anche il “tesoretto” personale di Luciano Moggi, stimato in 150 milioni di euro. Al solito, rogatorie e verifiche sono impossibili. Ma è certo che Moggi gode di grande considerazione in Vaticano. Difeso dalla stampa cattolica sempre, accolto nei pellegrinaggi a Lourdes dalla corte di Ruini, Moggi è da poco diventato titolare di una rubrica di “etica e sport” su Petrus, il quotidiano on-line vicino a papa Benedetto XVI, da dove l’ex dirigente juventino rinviato a giudizio ha subito cominciato a scagliare le prime pietre contro la corruzione (altrui).
Con l’immagine di Luciano Moggi maestro di morale cattolica si chiude l’ultima puntata dell’inchiesta sui soldi della Chiesa. I segreti dello IOR rimarranno custoditi forse per sempre nella torre-scrigno. L’epoca Marcinkus è archiviata ma l’opacità che circonda la banca della Santa Sede è ben lontana dallo sciogliersi in acque trasparenti. Si sa soltanto che le casse e il caveau dello IOR non sono mai state tanto pingui e i depositi continuano ad affluire, incoraggiati da interessi del 12 per cento annuo e perfino superiori. Fornire cifre precise è, come detto, impossibile. Le poche accertate sono queste. Con oltre 407 mila dollari di prodotto interno lordo pro capite, la Città del Vaticano è di gran lunga lo “stato più ricco del mondo”, come si leggeva nella bella inchiesta di Marina Marinetti su Panorama Economy. Secondo le stime della Fed del 2002, frutto dell’unica inchiesta di un’autorità internazionale sulla finanza vaticana e riferita soltanto agli interessi su suolo americano, la chiesa cattolica possedeva negli Stati Uniti 298 milioni di dollari in titoli, 195 milioni in azioni, 102 in obbligazioni a lungo termine, più joint venture con partner Usa per 273 milioni.
Nessuna autorità italiana ha mai avviato un’inchiesta per stabilire il peso economico del Vaticano nel paese che lo ospita. Un potere enorme, diretto e indiretto. Negli ultimi decenni il mondo cattolico ha espugnato la roccaforte tradizionale delle minoranze laiche e liberali italiane, la finanza. Dal tramonto di Enrico Cuccia, il vecchio azionista gran nemico di Sindona, di Calvi e dello IOR, la “finanza bianca” ha conquistato posizioni su posizioni. La definizione è certo generica e comprende personaggi assai distanti tra loro. Ma tutti in relazione stretta con le gerarchie ecclesiastiche, con le associazioni cattoliche e con la prelatura dell’Opus Dei. In un’Italia dove la politica conta ormai meno della finanza, la chiesa cattolica ha più potere e influenza sulle banche di quanta ne avesse ai tempi della Democrazia Cristiana.
 quival.it tutto quello che avresti voluto sapere ma non hai mai osato chiedere
quival.it tutto quello che avresti voluto sapere ma non hai mai osato chiedere